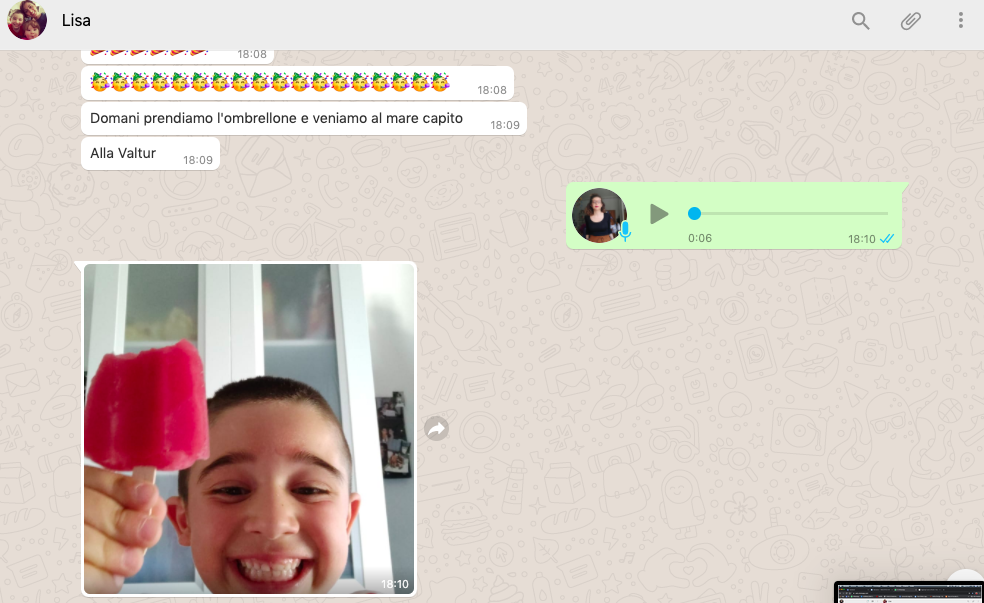Il mio piatto di spaghetti con le zucchine fritte aveva un non so che di distopico oggi a pranzo. Mi è sembrato l’ultimo atto di un futuro che avevo immaginato diverso, e soprattutto altrove. Oggi avrei terminato la mia sessione di esami estiva a Parma, sarei tornata a casa, magari con la valigia pronta sul letto e prima di chiudere tutto, avrei svuotato il frigo con l’ultima genovese sintetica comprata al supermercato Panorama a 500 metri da casa.
La pandemia ha avuto un effetto sliding doors, per certi versi. Una sola variabile è in grado di generare due futuri paralleli, con una me che contempla il tramonto al mare mentre l’altra risale la ciclabile di via La Spezia. Entrambe opzioni possibili, entrambe vere e sovrapponibili, perché convivono in me l’una e l’altra in un ciclo infinito che si ripete (sì, ho visto Dark di recente).
Se il futuro somiglia a un bivio biforcuto e diabolico, alle 13.23 oggi, attorcigliando quegli spaghetti, mi è stata chiara una cosa, sempre vera e sempre stata: c’è una costante nella mia storia, come in quella di ciascuno, e siamo proprio noi, artefici, attori, protagonisti e perfino antagonisti di noi stessi. Siamo la sorte che ci siamo dati e che influenza le vite degli altri, si intreccia con essa, scatta come una scintilla al contatto, a volte può perfino esplodere. O chiedere “Tutto bene per il resto?”. Si concludeva così la mail di un docente che mi avvertiva della pubblicazione di un pezzo che avevo scritto mesi fa.
Mi ha riportato lì, a quelle ore di biblioteca impiegate a cercare, intercettare, curiosare, ipotizzare storie. Ho iniziato con un gruppo di volontari che nel reparto di neonatologia dell’Ospedale di Parma si prende cura dei piccoli facendogli le coccole, ho cercato di capire perché trovare una stanza in affitto per gli studenti delle città del nord è diventato sempre più proibitivo, ho incontrato Marina Burani, Giuseppe Milano, e il Rettore dell’Università. E per ogni pezzo che alla fine ne veniva fuori c’erano dieci, cento cose che avevo imparato nel mio primo anno da fuori sede.
Quando guardavo lo scontrino della spesa e studiavo i volantini delle offerte, ho capito che non vorrei mai che i soldi rappresentassero un limite, ma anche che è necessario dare un prezzo alle cose che vogliamo, per esercitare la virtù della scelta, sempre, e se necessario rinunciare. Così ho rinunciato all’estetista, ma poi ho trovato una studentessa che se la cavava con le cerette e l’ho contattata. Una ceretta a buon mercato – ho imparato – può appagare il bisogno di sentirsi a posto con se stessi.
Ho scoperto di avere ancora 19 anni quella sera che il corridoio di casa divenne il campo di battaglia e noi, il bersaglio del gioco delle freccette. Ho sentito per la prima volta la nostalgia così come mi è chiaro adesso il motivo di ogni ripartenza. Che se perdo l’ultimo autobus delle 20, in Via Pellico posso tornarci a piedi, anche se è febbraio e fanno tre gradi. Ma non mi sono pesate quelle insolite temperature nei momenti in cui era più importante rimanere fuori, che tornare nella mia stanza.
Ho trovato più storie in un parco che nel centro storico della città, e ho capito che i docenti non sono solo l’ostacolo da superare prima di passare al prossimo esame. Ma opportunità, o anche no. Non per forza. Le persone sono stimoli, oppure rotture di balle. Difficilmente trovo una via di mezzo quando si tratta di altri.
Ho imparato che una compagnia non necessariamente è l’antidoto alla solitudine e che persino avere paura fa bene. Ho imparato a mangiare i ceci e le barbabietole, e a non crucciarmi se il limone non emana l’odore dell’orto. Che so fare il risotto, ma anche Just Eat va bene. Che posso darmi tregua e non devo per forza rimanere fregata se abbasso la guardia.
Ho imparato a chiedere aiuto se ho bisogno e a saltare su un treno per Roma, se serve un’amica a cui non devi spiegare chi sei prima di piangere sulla sua spalla. Ho imparato che se non metti il nome sul citofono, il corriere non ti trova e che mai, mai, mai bisogna fidarsi di chi parla troppo velocemente. Ho imparato che i dipendenti pubblici sono un sacco meridionali e che alcuni del nord pensano che i meridionali siamo scansafatiche che sanno cucinare bene.
Un anno fa decidevo di andarmene. Studiare era il modo più semplice per farlo, di studiare avevo bisogno; così, l’ho fatto e lo rifarò di nuovo, presto. Ho imparato che il fuori sede è un fuggitivo, un sognatore, un viziato, un pazzo, un avventuriero e un piagnone. Che farsi degli amici è difficile solo se scordi te stesso a casa per paura di perderlo. E che se ti esprimi, forse, allora, ti sembrerà di non essere neanche più te stesso, ma di amici probabilmente ne avrai…e anche di soddisfazioni.